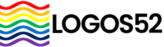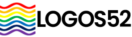È il romanzo d’esordio di Stefano Orsolini. Nel complesso, una buona prova giovanile (l’autore è poco più che ventenne), su un argomento attuale e difficile. Presenta aspetti critici che si risolveranno con la maturazione. Deve fare attenzione a non diventare oleografico: la vittoria dei perdenti è un evento raro. Questi i miei rilievi.
Aspetti linguistici e formali
- A volte il narratore si rivolge a Stefano, suo nipote, altre volte al lettore: non va bene, deve rivolgersi a un solo destinatario; deve sapere con chi parla. L’editor o il correttore di bozze dovevano accorgersi di questo erroraccio materiale, perché l’autore è assorbito da altre istanze.
- Ci sono diversi termini che si possono eufemisticamente definire inconsueti; allele li batte tutti, ma ci sono anche ossimorico e pleonastico. Si ha l’impressione che si voglia colpire qualcuno con l’uso di termini che non tutti capiscono. Si ricordi che Orsolini studia biologia.
Aspetti di gestione delle fonti
- Per scrivere sulla vita in prigione, occorrerebbe almeno averne visitata una o parlato con qualcuno che c’è stato recluso. Non si direbbe che si sia verificato alcunché del genere. Insomma, uno scrittore si dovrebbe documentare in maniera il più possibile diretta su quello che scrive, e questo non sembra essere avvenuto: sembra invece che parli della vita carceraria per sentito dire.
- Dice che quanti credono nella predestinazione diventano fatalisti e apatici, e questo fa a pugni con gli studi di Max Weber e di altri studiosi, che individuano nel calvinismo l’origine del capitalismo: colui che crede nella predestinazione, cerca nel successo sul lavoro i segni del benvolere di Dio nei suoi confronti, e diventa perciò imprenditore. Le parole di Max Weber valgono di più di quelle di Orsolini, almeno per ora.