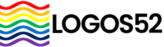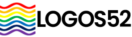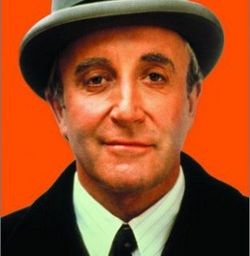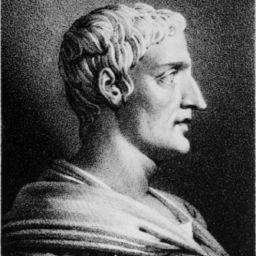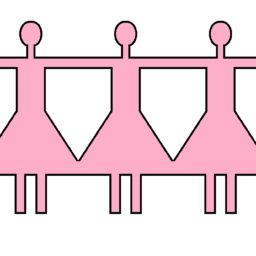Da Bonaccini alla scuola, passando per Peppone
Tempo fa (Aprile 2019) dicevamo che, per recuperare l’egemonia culturale perduta, la sinistra deve impegnarsi su tutte queste azioni: dare piena attuazione all’art. 34 della Costituzione; estendere a 18 anni l’obbligo scolastico; dare maggiori e migliori risorse all’istruzione, dal nido, all’università; sostenere le biblioteche e il loro uso anche in senso digitale; promuovere l’editoria cartacea e digitale; promuovere la cultura nella radio e nella televisione; sviluppare l’impegno pubblico nella rete.
Questo costituisce la nostra traccia, ma occorre vedere come queste indicazioni possano essere applicate localmente, in particolare nelle aree in cui la sinistra è maggiormente in difficoltà. Ma prima, una premessa.
L’errore più clamoroso che la sinistra potrebbe fare è quello di centralizzare. Quel che serve, invece, è liberare le forze sane locali, intendendo per forze sane quelle che vogliono dare un contributo alla comunità e che non si pongono obiettivi personali di prestigio o potere. Solo quelle forze conoscono la propria comunità e possono applicare nel modo migliore e più efficace scelte corrette e lungimiranti. Queste forze esistono, ma forse ci sono ancora difficoltà a rintracciarle e evidenziarle: è necessario fare uno sforzo in questa decisione, evitando di mettere la situazione nelle mani del “compagno venuto dalla città”, come nella Brescello di Peppone.
Coinvolgere!
Lo stesso vale per le azioni di cui sopra. Sembra ovvio che non su tutte è possibile agire localmente: restano escluse l’attuazione all’art. 34 e l’obbligo scolastico, mentre per radio, televisione e rete pubblica occorrono iniziative legislative specifiche; ma nelle altre, dove l’azione locale è possibile, il coinvolgimento non è optional. Quindi:
- Dare maggiori e migliori risorse all’istruzione, dal nido, all’università;
- Sostenere le biblioteche e il loro uso anche in senso digitale;
- Promuovere l’editoria cartacea e digitale.
Anche in questi casi, non si può pensare a una azione locale senza un contributo nazionale o regionale, normativo e finanziario, ma per l’applicazione il discorso è diverso, specialmente per le scuole e le biblioteche. Anche per l’editoria, comunque, si possono fare esempi di non poco conto: ci sono fior di associazioni, e anche di privati, che cercano editori per i propri scritti, che si tratti di articoli, bollettini, narrativa, poesia o altro. Non ci vuole molto a immaginare quanto si potrebbe fare se ce ne fossero i mezzi. Per le scuole, si è già detto: sessanta anni fa se ne sono costruite e aperte moltissime; oggi, per un malinteso risparmio, se ne sono chiuse molte, concentrando in poche sedi non solo le scuole specialistiche, ma anche quelle di base. Se per le scuole specialistiche ci può essere un senso (garantire qualità e attrezzature), per quelle di base si sono fatti gravi danni, e bisogna rimediare.
Un fenomeno da incoraggiare è anche quello delle piccole biblioteche che raccolgono libri usati per metterli a disposizione di altri lettori. Qui si tratta soprattutto di superare il concetto del libro come oggetto da possedere, promuovendone invece l’uso condiviso, che è lo scopo essenziale della biblioteca, ma non solo quello: una biblioteca ha anche bisogno di locali adatti, dotati di un ambiente adatto alla buona conservazione di libri e ipertesti, e di tutto quello che è necessario per la sicurezza di utenti e visitatori, e non è sempre semplice.
Fermiamoci qui.